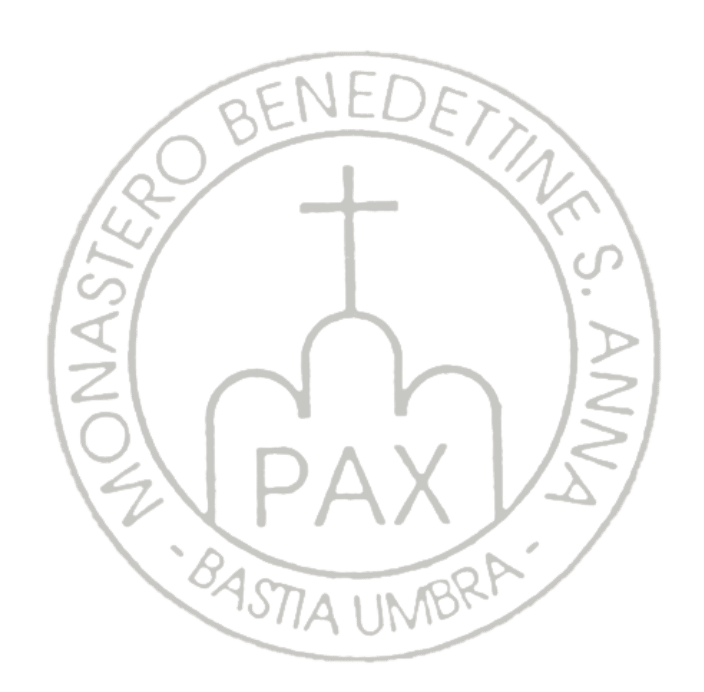Il Triduo Pasquale, culmine dell’anno liturgico nella tradizione della Chiesa cattolica, si configura, secondo l’insegnamento costante della *Sacrosanctum Concilium* (n. 5), come «la celebrazione del mistero pasquale di Cristo, della sua passione, morte e risurrezione», in un arco di tempo che si estende dalla sera del Giovedì Santo fino ai Vespri della Domenica di Risurrezione, tempo liturgico unitario e indivisibile, che, pur articolandosi in tre giorni distinti, esprime un unico mistero salvifico, cioè la Pasqua del Signore, «che passando da questo mondo al Padre, ha dato compimento all’opera della redenzione degli uomini» (cf. Gv 13,1).
Infatti, come scrive Origene, commentando la Pasqua nel suo *Omelia sulla Pasqua* (Omelia 2, SC 353), «Cristo è la nostra Pasqua immolata: e chi celebra la Pasqua veramente, lo fa nella sincerità e nella verità, non più con lievito vecchio, ma con il pane nuovo della vita eterna», e, in ciò, si comprende che il Triduo non è mera rievocazione storica, ma partecipazione sacramentale ed esistenziale all’evento centrale della fede cristiana, poiché – come ribadisce san Paolo – «se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede» (1Cor 15,17), e dunque vana sarebbe anche ogni celebrazione che non fosse fondata nella realtà viva del Risorto.
Il Giovedì Santo, segnato dalla *Missa in Cena Domini*, apre solennemente il Triduo e introduce il mistero dell’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio ministeriale, ma anche del mandatum, il comando dell’amore fraterno: «Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13,15). Questo gesto, che nel contesto della cultura giudaica del tempo implicava una radicale inversione dei ruoli sociali, è interpretato dai Padri, in particolare da Sant’Agostino, come segno sacramentale di un amore che si fa servizio fino all’umiliazione della croce: «Non c’è umiltà più grande dell’abbassarsi del Signore; e non c’è orgoglio più insensato che rifiutare di imitare ciò che fece chi ti creò» (*In Io. Ev.* 58,4).
Segue la notte del Getsemani, nella quale Cristo, «pieno di angoscia, sudava sangue» (cf. Lc 22,44), abbandonato dai suoi discepoli, vive il peso del peccato del mondo, mentre la liturgia lo contempla come «l’Agnello muto condotto al macello» (Is 53,7), e, nel silenzio adorante dell’altare della reposizione, la Chiesa veglia con lui, anticipando sacramentalmente il Venerdì della passione, in cui il Figlio, nell’ora più buia, offrirà la sua vita «in riscatto per molti» (Mt 20,28).
Il Venerdì Santo, giorno aliturgico, che non conosce la celebrazione eucaristica, è interamente consacrato alla meditazione del mistero della Croce, che, secondo Ireneo di Lione, è «il segno della vittoria di Dio, perché nella debolezza della carne fu distrutta la potenza della morte» (*Adversus haereses*, V,17,3). L’azione liturgica della Passione del Signore, che comprende la proclamazione solenne del racconto della Passione secondo Giovanni – il Vangelo nel quale la croce è già glorificazione – invita i fedeli a venerare la Croce come trono regale, dove il Re dell’universo, coronato di spine, regna donando la vita, e dove, in un gesto che non è semplice pietà ma confessione di fede, si proclama: *Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit*.
Secondo Hans Urs von Balthasar, nella sua opera *Mysterium Paschale*, «è proprio nella desolazione e nel silenzio del Sabato Santo che si rivela in tutta la sua profondità la kenosi del Figlio: Egli scende agli inferi, non solo come morto, ma come il Vivente che redime ogni tempo e ogni spazio, anche quello dell’abbandono e della morte». Il Sabato Santo, quindi, è giorno del silenzio del sepolcro, ma anche della custodia della speranza, perché come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 634), «Gesù è disceso nella profondità della morte affinché i morti udissero la voce del Figlio di Dio e coloro che l’ascoltano vivano».
La Veglia Pasquale, “madre di tutte le veglie” secondo Sant’Agostino (*Sermo 219*), nella notte fra il Sabato e la Domenica, è la celebrazione più solenne dell’anno, scandita da un’architettura rituale che, partendo dalla liturgia della luce – simbolo del Cristo risorto – passa attraverso la liturgia della Parola, che ripercorre la storia della salvezza, fino al culmine della liturgia battesimale ed eucaristica. In essa la Chiesa, nella persona dei catecumeni e dei fedeli rinnovati nello Spirito, entra sacramentalmente nella nuova vita, proclamando con il canto dell’Exsultet che «questa è la notte in cui Cristo ha spezzato le catene della morte e dai morti è risorto vittorioso».
La Domenica di Risurrezione, quindi, non è un semplice epilogo, bensì il compimento glorioso del mistero pasquale, che illumina retrospettivamente ogni gesto liturgico e ogni parola evangelica del Triduo, manifestando che il “Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani” (1Cor 1,23), è in realtà “potenza e sapienza di Dio”, perché in Lui la morte è vinta e la vita è restituita, non solo a Lui ma, per mezzo di Lui, a tutta l’umanità.
Come scrive il teologo Jean Daniélou nel suo *Saggio sul mistero pasquale*, «la Pasqua non è un momento tra gli altri: è l’asse attorno a cui ruota tutto il mistero cristiano, perché in essa il tempo si apre all’eternità, e la storia dell’uomo si congiunge definitivamente alla storia di Dio». Ecco perché il Triduo Pasquale non è solo il cuore dell’anno liturgico, ma anche il cuore del mistero della fede, nel quale ogni cristiano, attraverso la liturgia, la meditazione e la partecipazione sacramentale, è chiamato non solo a contemplare ma a entrare, come afferma la *Sacrosanctum Concilium* (n. 6), affinché «per la celebrazione dei misteri della redenzione, i fedeli siano riempiti della grazia della salvezza».
Infatti, come scrive Origene, commentando la Pasqua nel suo *Omelia sulla Pasqua* (Omelia 2, SC 353), «Cristo è la nostra Pasqua immolata: e chi celebra la Pasqua veramente, lo fa nella sincerità e nella verità, non più con lievito vecchio, ma con il pane nuovo della vita eterna», e, in ciò, si comprende che il Triduo non è mera rievocazione storica, ma partecipazione sacramentale ed esistenziale all’evento centrale della fede cristiana, poiché – come ribadisce san Paolo – «se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede» (1Cor 15,17), e dunque vana sarebbe anche ogni celebrazione che non fosse fondata nella realtà viva del Risorto.
Il Giovedì Santo, segnato dalla *Missa in Cena Domini*, apre solennemente il Triduo e introduce il mistero dell’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio ministeriale, ma anche del mandatum, il comando dell’amore fraterno: «Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13,15). Questo gesto, che nel contesto della cultura giudaica del tempo implicava una radicale inversione dei ruoli sociali, è interpretato dai Padri, in particolare da Sant’Agostino, come segno sacramentale di un amore che si fa servizio fino all’umiliazione della croce: «Non c’è umiltà più grande dell’abbassarsi del Signore; e non c’è orgoglio più insensato che rifiutare di imitare ciò che fece chi ti creò» (*In Io. Ev.* 58,4).
Segue la notte del Getsemani, nella quale Cristo, «pieno di angoscia, sudava sangue» (cf. Lc 22,44), abbandonato dai suoi discepoli, vive il peso del peccato del mondo, mentre la liturgia lo contempla come «l’Agnello muto condotto al macello» (Is 53,7), e, nel silenzio adorante dell’altare della reposizione, la Chiesa veglia con lui, anticipando sacramentalmente il Venerdì della passione, in cui il Figlio, nell’ora più buia, offrirà la sua vita «in riscatto per molti» (Mt 20,28).
Il Venerdì Santo, giorno aliturgico, che non conosce la celebrazione eucaristica, è interamente consacrato alla meditazione del mistero della Croce, che, secondo Ireneo di Lione, è «il segno della vittoria di Dio, perché nella debolezza della carne fu distrutta la potenza della morte» (*Adversus haereses*, V,17,3). L’azione liturgica della Passione del Signore, che comprende la proclamazione solenne del racconto della Passione secondo Giovanni – il Vangelo nel quale la croce è già glorificazione – invita i fedeli a venerare la Croce come trono regale, dove il Re dell’universo, coronato di spine, regna donando la vita, e dove, in un gesto che non è semplice pietà ma confessione di fede, si proclama: *Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit*.
Secondo Hans Urs von Balthasar, nella sua opera *Mysterium Paschale*, «è proprio nella desolazione e nel silenzio del Sabato Santo che si rivela in tutta la sua profondità la kenosi del Figlio: Egli scende agli inferi, non solo come morto, ma come il Vivente che redime ogni tempo e ogni spazio, anche quello dell’abbandono e della morte». Il Sabato Santo, quindi, è giorno del silenzio del sepolcro, ma anche della custodia della speranza, perché come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 634), «Gesù è disceso nella profondità della morte affinché i morti udissero la voce del Figlio di Dio e coloro che l’ascoltano vivano».
La Veglia Pasquale, “madre di tutte le veglie” secondo Sant’Agostino (*Sermo 219*), nella notte fra il Sabato e la Domenica, è la celebrazione più solenne dell’anno, scandita da un’architettura rituale che, partendo dalla liturgia della luce – simbolo del Cristo risorto – passa attraverso la liturgia della Parola, che ripercorre la storia della salvezza, fino al culmine della liturgia battesimale ed eucaristica. In essa la Chiesa, nella persona dei catecumeni e dei fedeli rinnovati nello Spirito, entra sacramentalmente nella nuova vita, proclamando con il canto dell’Exsultet che «questa è la notte in cui Cristo ha spezzato le catene della morte e dai morti è risorto vittorioso».
La Domenica di Risurrezione, quindi, non è un semplice epilogo, bensì il compimento glorioso del mistero pasquale, che illumina retrospettivamente ogni gesto liturgico e ogni parola evangelica del Triduo, manifestando che il “Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani” (1Cor 1,23), è in realtà “potenza e sapienza di Dio”, perché in Lui la morte è vinta e la vita è restituita, non solo a Lui ma, per mezzo di Lui, a tutta l’umanità.
Come scrive il teologo Jean Daniélou nel suo *Saggio sul mistero pasquale*, «la Pasqua non è un momento tra gli altri: è l’asse attorno a cui ruota tutto il mistero cristiano, perché in essa il tempo si apre all’eternità, e la storia dell’uomo si congiunge definitivamente alla storia di Dio». Ecco perché il Triduo Pasquale non è solo il cuore dell’anno liturgico, ma anche il cuore del mistero della fede, nel quale ogni cristiano, attraverso la liturgia, la meditazione e la partecipazione sacramentale, è chiamato non solo a contemplare ma a entrare, come afferma la *Sacrosanctum Concilium* (n. 6), affinché «per la celebrazione dei misteri della redenzione, i fedeli siano riempiti della grazia della salvezza».