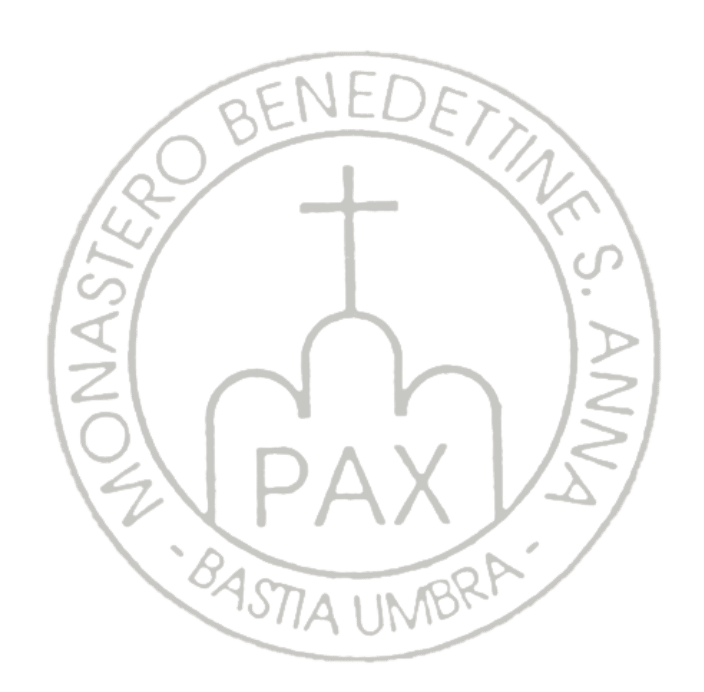Nel silenzio che segue la celebrazione della Cena del Signore, mentre l’altare spogliato e il tabernacolo vuoto evocano l’assenza e la veglia nell’Orto degli Ulivi, la lectio divina — che nella tradizione benedettina costituisce non solo una pratica spirituale, ma una modalità esistenziale di dimorare nella Parola — si offre come naturale prolungamento contemplativo del mistero celebrato.
Infatti, se nella liturgia “Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora il suo Vangelo” (Sacrosanctum Concilium, 33), è nella lectio, secondo l’insegnamento di San Benedetto, che il monaco (e con lui ogni cristiano) impara a rispondere a questa Parola, ad assimilarla interiormente, a lasciarsi progressivamente trasformare da essa, come argilla docile nelle mani del vasaio. “Ascolta, figlio, gli insegnamenti del Maestro, e inclina l’orecchio del tuo cuore” (RB Prologo, 1) — così inizia la Regola, indicando che l’ascolto della Parola non è operazione intellettuale, ma atto di amore, principio di conversione, inizio di comunione.
Nel contesto del Giovedì Santo, in particolare, la lectio divina si fa eco del Cenacolo e anticipo del Getsemani: leggere lentamente i capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni — dalla lavanda dei piedi al discorso sacerdotale — significa accompagnare Cristo nella sua ora, seguirlo non solo con la mente, ma con lo spirito e con il corpo, sostando con Lui in veglia orante, come chiede ai discepoli: “Restate qui e vegliate con me” (Mt 26,38). E proprio in questa veglia interiore, che è già partecipazione al mistero pasquale, si compie quanto Benedetto chiede: “Nulla anteporre all’amore di Cristo” (RB 4,21).
Come nota Enzo Bianchi, nel solco della spiritualità monastica, “la lectio è una mensa, e la Parola è il pane spezzato per l’ascolto: è anch’essa Eucaristia, seppure in forma verbale e interiore” — e in tal senso, vivere il Giovedì Santo significa non solo accostarsi all’altare, ma anche ritirarsi con la Scrittura aperta, lasciando che ogni parola sia accolta, masticata, pregata e custodita nel cuore, come faceva Maria.
La lectio benedettina si struttura, come noto, in quattro movimenti: lectio, meditatio, oratio e contemplatio, che in questo giorno acquistano una coloritura tutta pasquale: la lectio diventa memoriale dell’amore fino alla fine, la meditatio si concentra sull’umiltà di chi serve, l’oratio si fa preghiera d’intercessione — come quella di Gesù per i suoi — e la contemplatio, infine, è silenziosa adorazione del mistero del Corpo donato e del Sangue versato.
Così, mentre la notte avanza e il Triduo entra nella sua profondità più sacra, la lectio divina custodisce nel cuore del credente ciò che la liturgia ha consegnato alle sue mani: il mistero della carità, l’ora dell’obbedienza amorosa, la memoria di un Dio che si china e si dona, e che, proprio in questo, chiede a ciascuno di essere — a immagine del Figlio — servo, pane spezzato, parola offerta.
Madre Noemi
Infatti, se nella liturgia “Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora il suo Vangelo” (Sacrosanctum Concilium, 33), è nella lectio, secondo l’insegnamento di San Benedetto, che il monaco (e con lui ogni cristiano) impara a rispondere a questa Parola, ad assimilarla interiormente, a lasciarsi progressivamente trasformare da essa, come argilla docile nelle mani del vasaio. “Ascolta, figlio, gli insegnamenti del Maestro, e inclina l’orecchio del tuo cuore” (RB Prologo, 1) — così inizia la Regola, indicando che l’ascolto della Parola non è operazione intellettuale, ma atto di amore, principio di conversione, inizio di comunione.
Nel contesto del Giovedì Santo, in particolare, la lectio divina si fa eco del Cenacolo e anticipo del Getsemani: leggere lentamente i capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni — dalla lavanda dei piedi al discorso sacerdotale — significa accompagnare Cristo nella sua ora, seguirlo non solo con la mente, ma con lo spirito e con il corpo, sostando con Lui in veglia orante, come chiede ai discepoli: “Restate qui e vegliate con me” (Mt 26,38). E proprio in questa veglia interiore, che è già partecipazione al mistero pasquale, si compie quanto Benedetto chiede: “Nulla anteporre all’amore di Cristo” (RB 4,21).
Come nota Enzo Bianchi, nel solco della spiritualità monastica, “la lectio è una mensa, e la Parola è il pane spezzato per l’ascolto: è anch’essa Eucaristia, seppure in forma verbale e interiore” — e in tal senso, vivere il Giovedì Santo significa non solo accostarsi all’altare, ma anche ritirarsi con la Scrittura aperta, lasciando che ogni parola sia accolta, masticata, pregata e custodita nel cuore, come faceva Maria.
La lectio benedettina si struttura, come noto, in quattro movimenti: lectio, meditatio, oratio e contemplatio, che in questo giorno acquistano una coloritura tutta pasquale: la lectio diventa memoriale dell’amore fino alla fine, la meditatio si concentra sull’umiltà di chi serve, l’oratio si fa preghiera d’intercessione — come quella di Gesù per i suoi — e la contemplatio, infine, è silenziosa adorazione del mistero del Corpo donato e del Sangue versato.
Così, mentre la notte avanza e il Triduo entra nella sua profondità più sacra, la lectio divina custodisce nel cuore del credente ciò che la liturgia ha consegnato alle sue mani: il mistero della carità, l’ora dell’obbedienza amorosa, la memoria di un Dio che si china e si dona, e che, proprio in questo, chiede a ciascuno di essere — a immagine del Figlio — servo, pane spezzato, parola offerta.
Madre Noemi