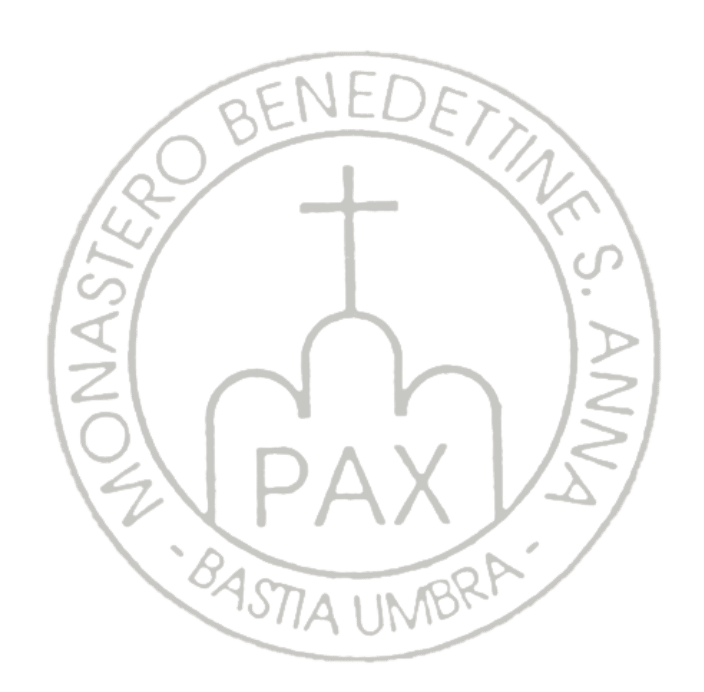Nella notte più luminosa dell’anno liturgico, che non è soltanto cronologicamente la vigilia della domenica di Pasqua, ma teologicamente il cuore stesso del tempo, il battito originario di una creazione rinnovata, la Chiesa — pellegrina nella storia e già partecipe delle realtà eterne — si raduna attorno al fuoco, veglia nella Scrittura, celebra nella liturgia, canta l’inno della luce e proclama con forza gioiosa che “Cristo è risorto dai morti, con la sua morte ha vinto la morte e a coloro che erano nei sepolcri ha dato la vita”.
La Veglia Pasquale, madre di tutte le veglie, come la definisce Sant’Agostino (Sermo 219), non è una semplice commemorazione della risurrezione di Gesù, ma il sacramento della Pasqua stessa, nel quale l’evento salvifico, già accaduto una volta per tutte nella storia, si rende presente nel mistero, si attualizza per noi, si dona alla Chiesa come fonte e culmine della sua esistenza. È in questa notte, nella quale — come canta il Preconio pasquale, il solenne Exsultet — “la colpa è stata redenta, il peccato è stato cancellato, la morte è stata vinta”, che la Chiesa scopre nuovamente la sua identità di popolo pasquale, redento, rinnovato, rigenerato dalla luce del Risorto.
Il racconto evangelico, nelle sue quattro versioni canoniche, ci presenta donne che si recano al sepolcro «all’alba del primo giorno della settimana» (Mt 28,1; Mc 16,2; Lc 24,1; Gv 20,1), trovando non più la pietra che sigillava la morte, ma un sepolcro vuoto, un angelo che annuncia, e, infine, il Risorto stesso che chiama per nome, come accade a Maria di Magdala: “Maria!” – “Rabbunì!” (Gv 20,16). È un incontro che rompe le categorie dell’umano, perché non si tratta di un ritorno alla vita come quella di Lazzaro, ma dell’ingresso definitivo del Figlio nella gloria, come afferma Paolo: “Cristo risorto dai morti non muore più: la morte non ha più potere su di lui” (Rm 6,9).
E proprio questo annuncio — che nel silenzio del sepolcro rotto dalle voci angeliche trova la sua forza — è al centro della teologia pasquale, che i Padri della Chiesa hanno esaltato con parole cariche di fuoco e di spirito: “Cristo è risorto e i demoni sono precipitati. Cristo è risorto e la vita regna. Cristo è risorto e non c’è più un morto nel sepolcro”, proclama San Giovanni Crisostomo nella sua celebre Omelia pasquale. Così anche Sant’Ireneo, nella sua Adversus Haereses (5,1,3), afferma: “La sua risurrezione è la garanzia della nostra risurrezione, e la primizia della nuova creazione”.
Tale mistero, che il Catechismo della Chiesa Cattolica descrive come “la verità culminante della fede in Cristo, creduta e vissuta come verità centrale dalla prima comunità cristiana” (CCC, 638), viene espresso nella Veglia attraverso una liturgia stratificata e progressiva, che, nella sua architettura sapienziale, ripercorre l’intera storia della salvezza: dalla creazione, attraverso l’Esodo, i profeti e l’alleanza, fino alla rivelazione piena nel Risorto.
La proclamazione del Preconio Pasquale, il lumen Christi che squarcia le tenebre della notte, è l’inizio mistico di questa celebrazione: la candela pasquale, accesa al fuoco nuovo, si innalza come colonna di luce, figura di Cristo, Alfa e Omega, principio e fine, che entra nel cuore della notte per illuminarla dall’interno. “Questa è la notte, o beata notte — canta il diacono o il presbitero — in cui il Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro”, ed è proprio in questa notte che l’ordine creato viene trasfigurato, il tempo rinnovato, l’uomo redento.
Come ha scritto Jean Daniélou, grande teologo del XX secolo, “la liturgia della Veglia è un’epifania del mistero pasquale nella sua totalità: la luce, la Parola, l’acqua, il pane e il vino si uniscono per esprimere, con un linguaggio non concettuale ma simbolico, il passaggio dalla morte alla vita” (Liturgie et Théologie, 1951).
In questa visione, la spiritualità benedettina, che ha fatto della liturgia delle ore, della lectio divina e della vigilanza interiore le sue vie maestre, trova nella Notte di Pasqua la sua più profonda risonanza: la Veglia diventa il culmine di quella conversatio morum — ossia di quella trasformazione costante del cuore — che la Regola chiede al monaco. “Vegliamo con Cristo nella notte, per essere trovati degni di entrare nella sua luce” — potremmo dire parafrasando il senso ultimo dell’Exsultet, che riecheggia nel cuore del chiostro, là dove ogni notte custodisce l’aurora.
Nel silenzio carico d’attesa del monastero — come in ogni chiesa che si illumina a poco a poco — la proclamazione dell’Alleluia rompe il lungo silenzio quaresimale, e non come un intermezzo emotivo, ma come il canto della vittoria, la voce della Sposa che ritrova lo Sposo, come dice San Gregorio di Nissa: “La notte pasquale è la notte nuziale della Chiesa, che si unisce al Cristo risorto per generare una nuova umanità”.
Ed è proprio in questa generazione nuova, sacramentalmente rappresentata dal battesimo e dalla rinnovazione delle promesse battesimali, che la Chiesa diventa madre, la fonte battesimale grembo fecondo, la Pasqua memoriale della nascita dell’uomo nuovo. “Sepolti con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova” (cf. Rm 6,4) — dice Paolo, e la liturgia pasquale lo rende visibile e reale. I Padri amavano dire: Pascha novorum hominum est — la Pasqua è la festa degli uomini rinnovati.
Infine, la liturgia eucaristica, vertice della veglia, non è semplice conclusione, ma consacrazione di tutta la notte: il Cristo risorto, presente realmente nel pane spezzato, come accadde per i discepoli di Emmaus, si dona alla Chiesa come cibo della vita eterna. “La notte si è illuminata come il giorno, l’oscurità è divenuta luce” — canta il salmo, e questo canto diventa vita, diventa sacramento, diventa missione.
Così, la Notte di Pasqua, nella sua mistagogia antica e sempre nuova, si offre al credente come sintesi della fede cristiana, come porta della vita eterna, come abbraccio nuziale tra Dio e l’uomo. E come scrive Romano Guardini: “Chi ha veramente vissuto la notte di Pasqua, sa che ogni altra notte, anche la più oscura, non sarà mai più senza luce”.
La Veglia Pasquale, madre di tutte le veglie, come la definisce Sant’Agostino (Sermo 219), non è una semplice commemorazione della risurrezione di Gesù, ma il sacramento della Pasqua stessa, nel quale l’evento salvifico, già accaduto una volta per tutte nella storia, si rende presente nel mistero, si attualizza per noi, si dona alla Chiesa come fonte e culmine della sua esistenza. È in questa notte, nella quale — come canta il Preconio pasquale, il solenne Exsultet — “la colpa è stata redenta, il peccato è stato cancellato, la morte è stata vinta”, che la Chiesa scopre nuovamente la sua identità di popolo pasquale, redento, rinnovato, rigenerato dalla luce del Risorto.
Il racconto evangelico, nelle sue quattro versioni canoniche, ci presenta donne che si recano al sepolcro «all’alba del primo giorno della settimana» (Mt 28,1; Mc 16,2; Lc 24,1; Gv 20,1), trovando non più la pietra che sigillava la morte, ma un sepolcro vuoto, un angelo che annuncia, e, infine, il Risorto stesso che chiama per nome, come accade a Maria di Magdala: “Maria!” – “Rabbunì!” (Gv 20,16). È un incontro che rompe le categorie dell’umano, perché non si tratta di un ritorno alla vita come quella di Lazzaro, ma dell’ingresso definitivo del Figlio nella gloria, come afferma Paolo: “Cristo risorto dai morti non muore più: la morte non ha più potere su di lui” (Rm 6,9).
E proprio questo annuncio — che nel silenzio del sepolcro rotto dalle voci angeliche trova la sua forza — è al centro della teologia pasquale, che i Padri della Chiesa hanno esaltato con parole cariche di fuoco e di spirito: “Cristo è risorto e i demoni sono precipitati. Cristo è risorto e la vita regna. Cristo è risorto e non c’è più un morto nel sepolcro”, proclama San Giovanni Crisostomo nella sua celebre Omelia pasquale. Così anche Sant’Ireneo, nella sua Adversus Haereses (5,1,3), afferma: “La sua risurrezione è la garanzia della nostra risurrezione, e la primizia della nuova creazione”.
Tale mistero, che il Catechismo della Chiesa Cattolica descrive come “la verità culminante della fede in Cristo, creduta e vissuta come verità centrale dalla prima comunità cristiana” (CCC, 638), viene espresso nella Veglia attraverso una liturgia stratificata e progressiva, che, nella sua architettura sapienziale, ripercorre l’intera storia della salvezza: dalla creazione, attraverso l’Esodo, i profeti e l’alleanza, fino alla rivelazione piena nel Risorto.
La proclamazione del Preconio Pasquale, il lumen Christi che squarcia le tenebre della notte, è l’inizio mistico di questa celebrazione: la candela pasquale, accesa al fuoco nuovo, si innalza come colonna di luce, figura di Cristo, Alfa e Omega, principio e fine, che entra nel cuore della notte per illuminarla dall’interno. “Questa è la notte, o beata notte — canta il diacono o il presbitero — in cui il Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro”, ed è proprio in questa notte che l’ordine creato viene trasfigurato, il tempo rinnovato, l’uomo redento.
Come ha scritto Jean Daniélou, grande teologo del XX secolo, “la liturgia della Veglia è un’epifania del mistero pasquale nella sua totalità: la luce, la Parola, l’acqua, il pane e il vino si uniscono per esprimere, con un linguaggio non concettuale ma simbolico, il passaggio dalla morte alla vita” (Liturgie et Théologie, 1951).
In questa visione, la spiritualità benedettina, che ha fatto della liturgia delle ore, della lectio divina e della vigilanza interiore le sue vie maestre, trova nella Notte di Pasqua la sua più profonda risonanza: la Veglia diventa il culmine di quella conversatio morum — ossia di quella trasformazione costante del cuore — che la Regola chiede al monaco. “Vegliamo con Cristo nella notte, per essere trovati degni di entrare nella sua luce” — potremmo dire parafrasando il senso ultimo dell’Exsultet, che riecheggia nel cuore del chiostro, là dove ogni notte custodisce l’aurora.
Nel silenzio carico d’attesa del monastero — come in ogni chiesa che si illumina a poco a poco — la proclamazione dell’Alleluia rompe il lungo silenzio quaresimale, e non come un intermezzo emotivo, ma come il canto della vittoria, la voce della Sposa che ritrova lo Sposo, come dice San Gregorio di Nissa: “La notte pasquale è la notte nuziale della Chiesa, che si unisce al Cristo risorto per generare una nuova umanità”.
Ed è proprio in questa generazione nuova, sacramentalmente rappresentata dal battesimo e dalla rinnovazione delle promesse battesimali, che la Chiesa diventa madre, la fonte battesimale grembo fecondo, la Pasqua memoriale della nascita dell’uomo nuovo. “Sepolti con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova” (cf. Rm 6,4) — dice Paolo, e la liturgia pasquale lo rende visibile e reale. I Padri amavano dire: Pascha novorum hominum est — la Pasqua è la festa degli uomini rinnovati.
Infine, la liturgia eucaristica, vertice della veglia, non è semplice conclusione, ma consacrazione di tutta la notte: il Cristo risorto, presente realmente nel pane spezzato, come accadde per i discepoli di Emmaus, si dona alla Chiesa come cibo della vita eterna. “La notte si è illuminata come il giorno, l’oscurità è divenuta luce” — canta il salmo, e questo canto diventa vita, diventa sacramento, diventa missione.
Così, la Notte di Pasqua, nella sua mistagogia antica e sempre nuova, si offre al credente come sintesi della fede cristiana, come porta della vita eterna, come abbraccio nuziale tra Dio e l’uomo. E come scrive Romano Guardini: “Chi ha veramente vissuto la notte di Pasqua, sa che ogni altra notte, anche la più oscura, non sarà mai più senza luce”.