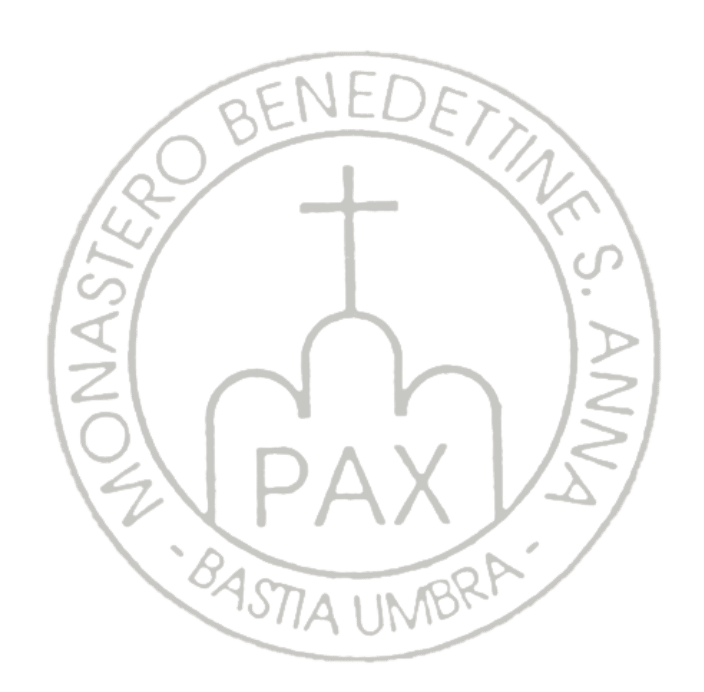Nel silenzio carico di mistero che avvolge il Venerdì Santo — giorno in cui, come annota l’antico Sacramentario Gelasiano, “la Chiesa non celebra l’Eucaristia, poiché è il Sposo stesso a essere tolto” — l’anima credente si trova dinanzi all’abisso della Croce, al vertice dell’umiliazione redentrice del Figlio di Dio, che “avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13,1), e che, proprio in questo amore spinto fino al dono supremo della vita, rivela il volto definitivo del Padre.
È infatti in questa ora — la sola, nei Vangeli, a essere chiamata “l’ora” per antonomasia — che si consuma il mistero della salvezza, anticipato nei segni profetici, vissuto nei gesti sacramentali del Giovedì Santo, e ora consegnato alla storia mediante il sacrificio del Calvario. “Tutto è compiuto” (Gv 19,30), esclama il Crocifisso, parole che non sono il segno di una sconfitta, ma il sigillo glorioso di un’opera compiuta nella totale obbedienza, che è, come ricorda San Paolo, “obbedienza fino alla morte, e alla morte di croce” (Fil 2,8), cioè obbedienza che trasforma il patire in atto regale, l’umiliazione in glorificazione, la morte in sorgente di vita.
La liturgia del Venerdì Santo, con la sua austera sobrietà e la sua forza espressiva, si presenta come vertice del mistero pasquale nella sua dimensione più densa e teologica: il silenzio dell’altare spoglio, l’adorazione della Croce, la solenne proclamazione della Passione secondo Giovanni, non sono meri simboli, ma veri atti di partecipazione sacramentale al Mistero che si celebra. Come nota il Catechismo della Chiesa Cattolica, “la Croce è il sacrificio unico di Cristo, ‘unico mediatore tra Dio e gli uomini’ (1 Tm 2,5), in cui si manifesta e si compie il suo amore redentore” (CCC, 613).
È nella narrazione giovannea della Passione (Gv 18–19) che la Chiesa trova la più alta espressione del mistero pasquale in forma narrativa e teologica: il Cristo che, pur apparendo catturato, giudicato, condannato e crocifisso, in realtà domina ogni scena, come Re glorioso che sale liberamente al trono della Croce. “Io sono” (Gv 18,5), dice Gesù ai soldati nel Getsemani, e quelli, udendo il Nome divino, retrocedono e cadono a terra. In questo gesto, carico di echi veterotestamentari (cf. Es 3,14), si manifesta il paradosso della gloria nella sofferenza, della potenza nella debolezza, della divinità che si rivela nella passione, tema centrale per tutta la patristica, da Ignazio di Antiochia a Ireneo di Lione, fino ad Agostino, il quale scrive: “La Passione di Cristo è la scuola suprema della carità, perché nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici” (In Iohannis Evangelium Tractatus, 119,7).
La spiritualità benedettina, profondamente radicata nella meditazione assidua della Scrittura e nella contemplazione del mistero di Cristo, accoglie la Croce non come evento remoto o tragedia da compatire, ma come forma della vita monastica, quotidiano cammino di sequela nella logica del “discendere per ascendere” (cf. RB 7). San Benedetto, nel settimo capitolo della sua Regola, dedicato all’umiltà — vertice ascetico della vita spirituale — descrive la progressione dell’anima che, mediante la conformazione al Cristo obbediente e sofferente, raggiunge la “carità perfetta che scaccia il timore”, carità che è frutto della Croce e della perseveranza sotto di essa.
Nella lectio divina, che per i monaci è alimento quotidiano, il racconto della Passione diventa luogo teologico ed esistenziale: leggere, meditare e interiorizzare il servus Dei dolens, il Servo sofferente, significa lasciarsi configurare a lui, assumere nella propria carne e nel proprio spirito la logica del seme che, se non muore, non porta frutto (cf. Gv 12,24). “Cristo non è disceso dalla Croce per insegnarci a non scendere da quella che ci è posta sulle spalle”, scrive Bernardo di Chiaravalle, in una delle più alte meditazioni sulla Croce. È proprio questo sguardo che il monaco benedettino impara a coltivare, giorno dopo giorno, nella solitudine del chiostro, ma anche nella fraternità concreta, nella pazienza dell’ascolto, nella perseveranza nell’obbedienza: ogni croce, se accolta con amore, diventa “gradino dell’umiltà” e quindi porta della Pasqua.
Nell’ufficio monastico del Venerdì Santo, tradizionalmente caratterizzato dal silenzio prolungato e dalla recitazione dei Salmi penitenziali, risuona la voce dell’Antico Testamento, che, lungi dall’essere messo da parte, trova nel Crocifisso la sua piena attuazione: “Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori… per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53,4-5). È il testo che, letto nella liturgia della Parola, diventa chiave interpretativa non solo della morte di Cristo, ma anche del senso cristiano del dolore e del sacrificio.
In tal senso, il Venerdì Santo non è tanto il giorno del lutto, quanto il giorno della verità: la Croce smaschera l’illusione di una gloria senza passaggio attraverso il male, e rivela che il vero potere è il dono, che la vera regalità è il servizio, che la vera vittoria è l’amore che non si ritrae. “La Croce — scrive Joseph Ratzinger — è l’atto in cui Dio ha mostrato, nel modo più radicale, che egli è amore; un amore che non si risparmia, ma che si espone all’abisso del rifiuto e del peccato per salvarne il colpevole” (Introduzione al Cristianesimo, 1968).
Per questo, nel rito dell’adorazione della Croce, ogni ginocchio che si piega, ogni bacio che sfiora il legno benedetto, è un atto di fede, di riconoscimento, di amore grato. “Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit: venite, adoremus” — questo grido liturgico, che risuona nella penombra delle chiese e nei cori monastici, diventa invito alla contemplazione, non del dolore fine a sé stesso, ma del dolore trasfigurato, del legno che, da strumento di tortura, è divenuto albero della vita.
Così, il Venerdì Santo — letto, pregato, vissuto nella luce della spiritualità benedettina — si configura come il giorno dell’obbedienza amorosa, della conformazione al Cristo Crocifisso, della speranza che nasce dalla fedeltà fino alla fine. In esso, la Chiesa non piange soltanto la morte del suo Signore, ma la contempla come mistero di grazia, fonte di salvezza, cattedra di verità. E il monaco, ma insieme a lui ogni credente che ama e cerca il volto di Dio, riconosce nella Croce l’unico luogo in cui il cuore trova pace, e la vita trova senso.
È infatti in questa ora — la sola, nei Vangeli, a essere chiamata “l’ora” per antonomasia — che si consuma il mistero della salvezza, anticipato nei segni profetici, vissuto nei gesti sacramentali del Giovedì Santo, e ora consegnato alla storia mediante il sacrificio del Calvario. “Tutto è compiuto” (Gv 19,30), esclama il Crocifisso, parole che non sono il segno di una sconfitta, ma il sigillo glorioso di un’opera compiuta nella totale obbedienza, che è, come ricorda San Paolo, “obbedienza fino alla morte, e alla morte di croce” (Fil 2,8), cioè obbedienza che trasforma il patire in atto regale, l’umiliazione in glorificazione, la morte in sorgente di vita.
La liturgia del Venerdì Santo, con la sua austera sobrietà e la sua forza espressiva, si presenta come vertice del mistero pasquale nella sua dimensione più densa e teologica: il silenzio dell’altare spoglio, l’adorazione della Croce, la solenne proclamazione della Passione secondo Giovanni, non sono meri simboli, ma veri atti di partecipazione sacramentale al Mistero che si celebra. Come nota il Catechismo della Chiesa Cattolica, “la Croce è il sacrificio unico di Cristo, ‘unico mediatore tra Dio e gli uomini’ (1 Tm 2,5), in cui si manifesta e si compie il suo amore redentore” (CCC, 613).
È nella narrazione giovannea della Passione (Gv 18–19) che la Chiesa trova la più alta espressione del mistero pasquale in forma narrativa e teologica: il Cristo che, pur apparendo catturato, giudicato, condannato e crocifisso, in realtà domina ogni scena, come Re glorioso che sale liberamente al trono della Croce. “Io sono” (Gv 18,5), dice Gesù ai soldati nel Getsemani, e quelli, udendo il Nome divino, retrocedono e cadono a terra. In questo gesto, carico di echi veterotestamentari (cf. Es 3,14), si manifesta il paradosso della gloria nella sofferenza, della potenza nella debolezza, della divinità che si rivela nella passione, tema centrale per tutta la patristica, da Ignazio di Antiochia a Ireneo di Lione, fino ad Agostino, il quale scrive: “La Passione di Cristo è la scuola suprema della carità, perché nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici” (In Iohannis Evangelium Tractatus, 119,7).
La spiritualità benedettina, profondamente radicata nella meditazione assidua della Scrittura e nella contemplazione del mistero di Cristo, accoglie la Croce non come evento remoto o tragedia da compatire, ma come forma della vita monastica, quotidiano cammino di sequela nella logica del “discendere per ascendere” (cf. RB 7). San Benedetto, nel settimo capitolo della sua Regola, dedicato all’umiltà — vertice ascetico della vita spirituale — descrive la progressione dell’anima che, mediante la conformazione al Cristo obbediente e sofferente, raggiunge la “carità perfetta che scaccia il timore”, carità che è frutto della Croce e della perseveranza sotto di essa.
Nella lectio divina, che per i monaci è alimento quotidiano, il racconto della Passione diventa luogo teologico ed esistenziale: leggere, meditare e interiorizzare il servus Dei dolens, il Servo sofferente, significa lasciarsi configurare a lui, assumere nella propria carne e nel proprio spirito la logica del seme che, se non muore, non porta frutto (cf. Gv 12,24). “Cristo non è disceso dalla Croce per insegnarci a non scendere da quella che ci è posta sulle spalle”, scrive Bernardo di Chiaravalle, in una delle più alte meditazioni sulla Croce. È proprio questo sguardo che il monaco benedettino impara a coltivare, giorno dopo giorno, nella solitudine del chiostro, ma anche nella fraternità concreta, nella pazienza dell’ascolto, nella perseveranza nell’obbedienza: ogni croce, se accolta con amore, diventa “gradino dell’umiltà” e quindi porta della Pasqua.
Nell’ufficio monastico del Venerdì Santo, tradizionalmente caratterizzato dal silenzio prolungato e dalla recitazione dei Salmi penitenziali, risuona la voce dell’Antico Testamento, che, lungi dall’essere messo da parte, trova nel Crocifisso la sua piena attuazione: “Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori… per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53,4-5). È il testo che, letto nella liturgia della Parola, diventa chiave interpretativa non solo della morte di Cristo, ma anche del senso cristiano del dolore e del sacrificio.
In tal senso, il Venerdì Santo non è tanto il giorno del lutto, quanto il giorno della verità: la Croce smaschera l’illusione di una gloria senza passaggio attraverso il male, e rivela che il vero potere è il dono, che la vera regalità è il servizio, che la vera vittoria è l’amore che non si ritrae. “La Croce — scrive Joseph Ratzinger — è l’atto in cui Dio ha mostrato, nel modo più radicale, che egli è amore; un amore che non si risparmia, ma che si espone all’abisso del rifiuto e del peccato per salvarne il colpevole” (Introduzione al Cristianesimo, 1968).
Per questo, nel rito dell’adorazione della Croce, ogni ginocchio che si piega, ogni bacio che sfiora il legno benedetto, è un atto di fede, di riconoscimento, di amore grato. “Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit: venite, adoremus” — questo grido liturgico, che risuona nella penombra delle chiese e nei cori monastici, diventa invito alla contemplazione, non del dolore fine a sé stesso, ma del dolore trasfigurato, del legno che, da strumento di tortura, è divenuto albero della vita.
Così, il Venerdì Santo — letto, pregato, vissuto nella luce della spiritualità benedettina — si configura come il giorno dell’obbedienza amorosa, della conformazione al Cristo Crocifisso, della speranza che nasce dalla fedeltà fino alla fine. In esso, la Chiesa non piange soltanto la morte del suo Signore, ma la contempla come mistero di grazia, fonte di salvezza, cattedra di verità. E il monaco, ma insieme a lui ogni credente che ama e cerca il volto di Dio, riconosce nella Croce l’unico luogo in cui il cuore trova pace, e la vita trova senso.